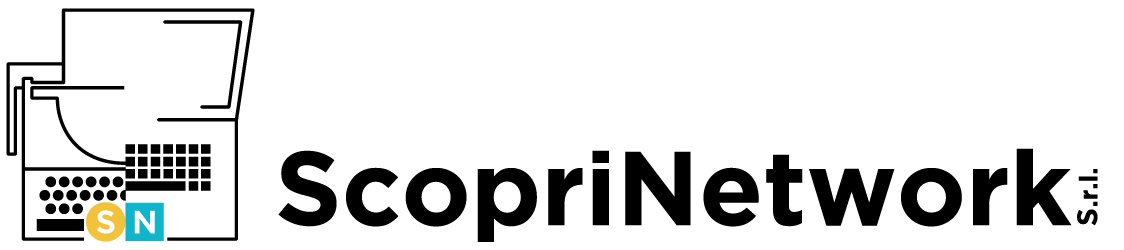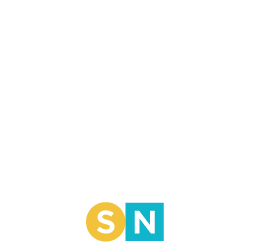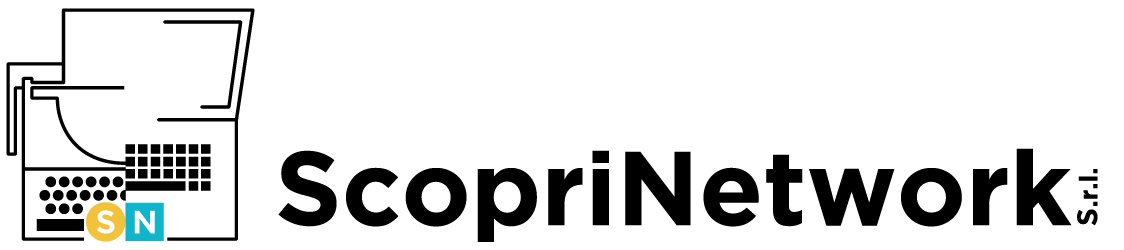Ottant’anni fa, l’Italia si liberava dal regime fascista. Il 25 aprile 1945 non fu solo l’atto finale di un conflitto, ma l’inizio di una nuova narrazione collettiva. Da quel giorno di primavera del 1945, la Festa della Liberazione è diventata una ricorrenza fondamentale per ricordare un periodo buio della storia italiana. E a scrivere quella narrazione non furono solo i partigiani con le armi, ma anche i comunicatori clandestini, le staffette, le redazioni improvvisate, le voci trasmesse via etere. Perché ogni atto di resistenza inizia con una parola, con un segno, con un simbolo capace di infrangere il silenzio imposto.
La consapevolezza, infatti, non può nascere nel vuoto: richiede accesso alla libertà di parola e alla libertà di stampa, come scrisse George Orwell nel suo romanzo distopico 1984: “Finché non diventano coscienti non si ribelleranno, e finché non si sono ribellati non possono diventare coscienti.”
“Aldo dice 26×1”: il messaggio che ha cambiato tutto
“Aldo dice 26×1” è una delle frasi più iconiche della Resistenza italiana. Semplice, codificata, incisiva. Apparve sui telex, sugli appunti scritti a mano, sui muri: era il segnale convenuto per dare il via all’insurrezione generale contro il nazifascismo nel Nord Italia. Quel messaggio, oggi, si potrebbe paragonare agli hashtag virali: un codice condiviso da una comunità, un’espressione identitaria, un atto comunicativo che mobilita senza spiegare. Non servivano spiegazioni, chi doveva capire capiva.
Come accade con gli slogan di oggi — da #MeToo a #MahsaAmini — anche “Aldo dice 26×1” era un messaggio breve, incisivo, capace di attivare un’intera rete di persone in ascolto. In quel frammento linguistico, c’era la chiamata all’azione, la consapevolezza che non si era soli, il coraggio di rompere il silenzio. Era, in senso moderno, un tormentone della libertà.
Piazza Tienanmen, triangoli, slogan: la grammatica universale della resistenza
Non è solo la storia italiana a raccontare la forza della comunicazione nella liberazione. La foto dell’uomo con la borsa che, da solo, blocca una colonna di carri armati in piazza Tienanmen (1989) è un esempio potente di comunicazione visiva: nessuna parola, ma un messaggio globale, irripetibile, immediatamente riconoscibile.
Allo stesso modo, nel femminismo contemporaneo, il gesto delle mani a triangolo con la punta rivolta verso l’alto (simboleggiando il sesso femminile) è diventato un atto politico, visivo, di rottura. Una forma di comunicazione non verbale, ma fortemente codificata, usata nelle proteste contro la violenza sulle donne in tutto il mondo..
Nei mesi recenti, questa icona in particolare ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori dei linguaggi visivi: il triangolo con la punta rivolta verso il basso, usato da Hamas nel proprio emblema, è stato ripreso, modificato o reinterpretato in numerosi contenuti sui social, generando reazioni, critiche e confusione simbolica.
Per i professionisti della comunicazione, questo è un terreno scivoloso ma fondamentale: bisogna saper leggere i codici, comprenderne l’origine, l’evoluzione e l’impatto.
La comunicazione, soprattutto in un’epoca di viralismi assume un ruolo determinante nei processi storici. Slogan come “Ni una menos”, “Je suis Charlie”, “I can’t breathe” o “We are the 99%” hanno costruito vere e proprie narrazioni alternative a quelle ufficiali. Frasi semplici, ripetute, memetiche. Ma potentissime. Come “Aldo dice 26×1”.Difendere la parola libera, ieri e oggi
Il libero scambio di idee e informazioni è la spina dorsale di ogni democrazia. Nella Festa della Liberazione ricordiamo quanto sia fondamentale difendere il diritto di espressione
Perché la comunicazione — lo abbiamo visto anche nei linguaggi della Resistenza — non è mai neutra. E i simboli, anche quelli geometrici, sono strumenti potenti: attivano identità, emozioni, memorie.Nel nostro lavoro quotidiano di comunicatori, è essenziale chiedersi sempre: che cosa sta davvero dicendo questo segno?, che cosa attiva negli occhi di chi guarda? In un mondo in cui ogni simbolo può diventare virale, serve più che mai una consapevolezza strategica e culturale. Oggi come allora, ogni gesto comunicativo può essere un atto politico. Un hashtag, un gesto, una frase scritta su un muro. La storia ce lo insegna. A noi il compito di ascoltarla.